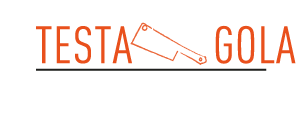La bottiglia che il cuore non vuole stappare
- Mario Crosta
- Ti potrebbe interessare Autori, Un sorso di, Vino e olio

Oggi il mondo del vino è completamente diverso da quello di appena mezzo secolo fa, sembra ieri.
Allora non c’erano neppure le DOC, molti vendevano vino sfuso, in damigiana, soltanto pochissimi imbottigliavano ed erano ancora più rari gli esportatori. Perciò sono rimasto veramente scioccato da un ottimo commento dei vini più amati della mia gioventù riassaggiati dopo più di trent’anni dagli esperti di uno dei più rispettati commercianti americani di vini da collezione che era apparso nelle newsletters di The Rare Wine Co.
Il primo vino, come il primo amore, non si scorda mai, e mi piace sempre davvero poter leggere fra le pagine del web i racconti delle prime bottiglie, di quei vini cioè che ciascuno ricorda per l’immenso piacere che gli hanno procurato agli inizi della propria passione per il re della tavola. Il mio fu uno straordinario Spanna del 1947 di Antonio Vallana e Figlio (Bernardo), un’azienda di Maggiora in provincia di Novara. Ne trovammo la bottiglia subito dopo l’alluvione del 1969, mentre liberavamo delicatamente dal fango un’abitazione di Vallemosso, dove, con un bel gruppo di studenti della mia scuola, l’Istituto Tecnico Industriale Statale ”Omar” di Novara, ci eravamo subito trasferiti per dare una mano a spalare.
La radio diceva che la situazione era pienamente sotto controllo, al Comando della Piazza Militare non volevano darci il permesso di passare e il preside non era tanto ben disposto a lasciar partire squadre di volontari a turni di due settimane per spalare fango fino a chissà quando. Ma lassù la situazione era disperata, interi paesi senz’acqua, senza viveri, senza più case né officine, con molti dispersi da ritrovare. Mio padre, aviatore negli ultimi mesi di guerra e amico di qualche alto ufficiale in tutte le armi, provò a darci una mano e alla fine riuscimmo ostinatamente a partire per un’esperienza che ci cambiò la vita.
Con noi riuscì a superare i blocchi anche un autobus di scaricatori del porto di Genova. Ricordo uno di loro, un magrolino che aveva visto che in quattro non riuscivamo a spostare un tronco d’albero e in silenzio, senza chiedere una mano a nessuno, l’afferrò da solo, lo sollevò e se lo portò via in spalla come se fosse stato un fiammifero. Da lontano quei tronchi d’albero che spuntavano dalle finestre delle fabbriche sepolte dal fango sembravano davvero dei fiammiferi che uscivano da una scatola, ma pesavano diversi quintali e non riuscivo davvero a capire come si potesse essere tanto magri e tanto forti.
Un giorno lo stesso portuale sollevò di peso un carabiniere prendendolo per il bavero con una sola mano e mentre l’altra si preparava ad un pugno di chissà quale potenza, vidi un suo saggio compagno aprirne le dita e infilarci il collo di un fiasco di vino rosso. Mentre il giovane carabiniere sgambettava a mezz’altezza, il nostro forzuto decise di bere invece di… chissà, quindi lasciò la presa e sorrise all’uomo in divisa come se non fosse successo nulla. Fu in quel momento che scoprii la forza del vino e le istruzioni per una civile convivenza che il colonnello Viviani riusciva comunque a mantenere bene anche fra gente non avvezza a nessuna disciplina. Infatti, poi divenne generale.
Perciò quando la nonnina di quella piccola casa invasa dal fango fin sopra i letti (e quelli di allora bisognava scalarli…) che in quattro aiutammo a ripulire interamente in tre giorni ci regalò quella bottiglia, estratta intera dalla dispensa appena liberata, decidemmo di bercela quella sera stessa. Alberto Imazio di Ghemnme, Marco Plata di Novara, il Traversa di Genova ed io. Una bottiglia in quattro, un bel nebbiolo di Traversagna invecchiato ben 22 anni, pane, salame e fagioli in scatola perché non avevamo altro, ma cantammo per tutta la notte dopo esserci raccontati millanta barzellette per qualche ora, fino all’alba.
Il primo vino che potei acquistare nella mia vita, con la paghetta da studente, risparmiando sulle nazionali (che riuscii però a scroccare per un mese) non poteva che essere quindi uno Spanna e non poteva che provenire dalla stessa cantina. Comprai perciò lo Spanna dei Cinque Castelli del 1964 dei Vallana, quello con l’aquila bene in vista, una bottiglia che è stata la capostipite della mia cantinetta, seguita a ruota da un Barbera del 1964 sempre dei Vallana che mi regalò un vero amico, Angelo Bersani (partigiano comunista e staffetta personale del commissario politico delle divisioni Garibaldi di Valsesia, Verbano, Cusio, Ossola Vincenzo ”Cino” Moscatelli) quand’era responsabile del Rifugio Castiglioni del Soccorso Alpino dell’Alpe Devero.
Un po’ alla volta, facendomi una cultura del vino, cominciai davvero a scegliere. Ma tutte le prime bottiglie erano comprate con l’occhio al portafoglio (160.000 lire di stipendio, di cui 80.000 solo per l’affitto), oltre che con l’ammirazione anche per tutti gli altri diversi nebbioli e barbera dalle eccezionali potenzialità di invecchiamento di questa piccola cantina: Spanna della Traversagna, dei Campi Raudii, della Cantina del Camino, del Castello di Montalbano, di San Lorenzo, Barbera della Cantina di Bacco. Non ho mai aperto nessuna di queste bottiglie prima che fossero trascorsi almeno vent’anni dalla vendemmia.
Questi vini avevano un’acidità meravigliosa e, da giovani, dei tannini dal sapore rustico, perciò me li assaggiavo con le pietanze tipiche servite nei vari circoli delle province di Novara e Vercelli dove facevo tappa in moto, una Gilera 125 o una Mondial 175, o in auto, una Fiat ‘500 con le portiere che si aprivano controvento. Ma le mie bottiglie erano gelosamente riservate tutte soltanto per delle grandi occasioni, come ricorda bene il Dino, detto il sindacone, che capitò a sorpresa con Gianni e l’Armando la sera che decidemmo di mandare in onorata pensione un Barbaresco Riserva di Enrico Serafino del 1952, la mia data di nascita, in occasione della svolta dei miei 33 anni.
Tutti vini che ancora si fregiavano in etichetta di varie medaglie d’oro e d’argento, perché non erano ancora stati emanati i primi regolamenti DOC che, quando arrivarono in zona provocarono una vera morìa di etichette a favore di altre ben più blasonate, come Ghemme, Boca e Gattinara. Vini superbi, maestosi, austeri, dai profumi profondi e mai immediati, che non vennero rovinati dalle barriques e quindi non trovarono poi spazio sulle tendenziose guide che cominciavano a spuntare e moltiplicarsi come funghi a marchette di due cartoni per due bicchieri, tre cartoni per tre chiocciole, niente cartoni niente stelle.
Ancora tutt’oggi le Cantine Antonio Vallana e Figlio, che hanno sempre venduto in zona ed esportato in America senza nessun bisogno di pubblicità, non ricorrono ai moderni trucchi del marketing, non foraggiano le salottiere iniziative romane, anzi continuano a fare il vino come hanno sempre fatto i padri e i nonni e fanno gli sponsor alla vecchia maniera, per esempio al Palio delle Botti di Maggiora, alla Corsa delle Botti Trofeo Torre d’Argento Città di Gattinara e alle belle passeggiate di gruppo fra le colline organizzate dall’enoteca del Gattinara, insomma appassionando il pubblico locale con uno spirito da gentiluomini d’altri tempi.
Ricordo ancora perfettamente la strada per arrivare alla loro cantina e ad almeno tre delle loro vigne fra i boschi. Sono passati decenni. Hanno realizzato superstrade e autostrade a destra e a manca, pure la ferrovia ad alta velocità e sulla provinciale, dove ricordo un boschetto famoso per i suoi porcini di giugno, i fioroni o le primizie come cavolo li chiamano, adesso c’è una marea di villette a schiera. Non saprei più dove svoltare, eppure con la bici da corsa ci sarò passato e ripassato qualche decina di volte.
Ah… benedetta gioventù! Il mondo corre così in fretta che fra un po’ perfino i videocellulari passeranno alla preistoria. Ogni paese della Traversagna, tra la Valsesia e il lago d’Orta, rappresenta una sorpresa. Qui non c’è più il circolo delle bocce, là non esiste più nemmeno il caseggiato dell’osteria che d’estate offriva le rane impanate e d’inverno il salam ‘dla duja, son sparite le anguriere e mannaggia quante megastazioni di benzina! Ma con la fantasia ci arrivo in un attimo. Mi basta guardare l’etichetta dell’ultima bottiglia che ha passato con me tante peripezie e che ho deciso di non stappare per lasciarla alle prossime generazioni. L’amore sa offrire ai figli e nipoti anche la gioia della scoperta di gusti irripetibili, ma può farlo soltanto con dei gioielli veramente unici, come i vini Vallana di quel periodo che sono stati tutti eccezionalmente longevi.
È stato dunque un grande piacere scoprire, per caso, di non essere l’unico a pensarlo. Ho trovato, infatti, dei giudizi di gente che non è certo l’ultima arrivata nel mondo del vino e che riporto nella lingua originale, per non sbagliarmi a tradurre. Burton Anderson nel 1980 aveva scritto, per esempio: ”Vallana creates Spannas with extraordinary life spans… their breeding, substance and longevity showing no compromise whatever with conceptions of mass consumerism… Vallana’s subcellars contain Spanna of the last half-century…. These are bargains for their age”. Robert Parker nel 1989 aveva precisato inoltre: ”Intense, traditionally made wines that ooze with character… Vallana’s wines can age for 20-25 years as evidenced by his 1958’s and 1964’s, which I recently tasted and found to be still in superb condition”. E Sheldon Wasserman nel 1990 aveva scritto infine: ”Vallana was a master blender who produced some very fine and long-lived Spannas worthy of three and four stars (Wasserman’s highest rating)… the wines were magnificent”.
Se lo hanno capito anche loro, e in tempi non sospetti, significa che anche nel campo del vino a volte le belle cenerentole possono diventare principesse. Senza nulla togliere ai meritevoli pluriosannati del giorno d’oggi, è bene ricordare che il vino buono, di grande valore, lo fa l’uva migliore, col sole, con la terra e con il genio e la pazienza infinita del vignaiolo. Bernardo Vallana nel 1980 mi aveva raccontato come il nonno, ormai vecchio, follava personalmente a mano i mosti in fermentazione, dormendo quasi niente. Non si fidava d’altro che del suo bastone, ma che gesto d’amore stupendo per un prodotto così tanto ben curato. Allora, di fronte a persone di questa statura morale si rimaneva in rispettoso silenzio, in ammirazione.
Oggi questi pionieri si terrebbero invece ben lontani dalla pletora delle diatribe sulla barrique, sui lieviti selezionati o sugli esperimenti con uve di cabernet sauvignon o syrah. Un Piemonte capovolto che più non gli appartiene, che venderà sicuramente tante belle chiacchiere, tante belle etichette griffate, ma con vini che non arriveranno nemmeno alla metà degli anni d’invecchiamento dei più semplici, ma genuini, sani, Nebbioli e Barbera di una volta. Patetici nelle loro etichette (che era comunque già un lusso potersi permettere) che oggi sono fuori moda in quanto in gran parte scure a sfondo marrone come il legno delle botti e con dei disegni semplicissimi, perché il vino andava prima in osteria, non nei saloni delle enoteche o fra le vetrine dei wine bar, dovremmo scoprirli ancora, che fa piacere ringiovanire un po’ anche soltanto a parlarne. E lasciamone qualcuno dimenticato apposta per i nati nel terzo millennio, che riescano a goderseli in santa pace alla facciazza degli odierni e futuri alchimisti cui li vorrebbe consegnare un’enologia più sensibile alle luci della ribalta che all’umiltà dei grandi silenzi.
Mario Crosta

Di formazione tecnica industriale è stato professionalmente impegnato fin dal 1980 nell’assicurazione della Qualità in diverse aziende del settore gomma-plastica in Italia e in alcuni cantieri di costruzione d’impianti nel settore energetico in Polonia, dove ha promosso la cultura del vino attraverso alcune riviste specialistiche polacche come Rynki Alkoholowe e alcuni portali specializzati come collegiumvini.pl, vinisfera.pl, winnica.golesz.pl, podkarpackiewinnice.pl e altri. Ha collaborato ad alcune riviste web enogastronomiche come enotime.it, winereport.com, acquabuona.it e oggi scrive per lavinium.it, nonché per alcuni blog. Un fico d’India dal caratteraccio spinoso e dal cuore dolce, ma enostrippato come pochi.